
IL DOLORE: NON SOLO UN SINTOMO, MA UNA PATOLOGIA
Era il 12 ottobre del 2011 quando, invitati dalla Deputata Europea (MEP) Françoise Grossetête, l’Executive Board della European Federation of IASP Chapters (EFIC) si riunì con il proprio Council nel Parlamento Europeo, a Brussels. Era il tentativo di sensibilizzare la politica al tema dolore. Una riunione simile era stata fatta due anni prima, sempre ospiti della stessa MEP, per presentare un documento dal titolo “The burden of chronic pain”. Quel documento era molto generale ed era indirizzato, in modo precipuo, a giornalisti e politici, spiegando quanto importante fosse il dolore per i sistemi sanitari e sociali, e facendo riflettere ognuno dei presenti che il dolore fisico era presente in tutte le loro famiglie e anche fra i loro conoscenti e amici. In quella occasione la risonanza della stampa fu limitata e la sensibilizzazione della politica scarsa.
Nella riunione dell’ottobre 2011, fatta con il Council EFIC al gran completo, si lanciò una iniziativa, la European Week Against Pain (EWAP), che era destinata a durare nel tempo e ad essere presentata nei vari Paesi europei, da parte delle associazioni locali per lo studio del dolore. Per l’Italia, la foriera dei messaggi internazionali era (ed è) l’AISD-FPP. In questa occasione, fra l’altro, fu presentato un ulteriore documento a firma di tutti coloro che, in Europa, dedicavano le loro attività scientifiche e cliniche ai malati con dolore. Quel documento ebbe come titolo “Europe against pain”, che era lo slogan della riunione e delle future EWAP; una vera dichiarazione di guerra. Il documento in questione consisteva in una accorta disamina dello stato attuale delle conoscenze fisiopatologiche sul dolore e in una attenta selezione di quanto di più rilevante la ricerca metteva a disposizione del clinico. Per la prima volta, almeno a mia conoscenza, si dimostrava scientificamente e in modo molto semplice, comprensibile anche a giornalisti e politici, come il dolore cronico fosse una patologia nosograficamente ben precisa, una malattia a sé stante (…a disease in its own right…).
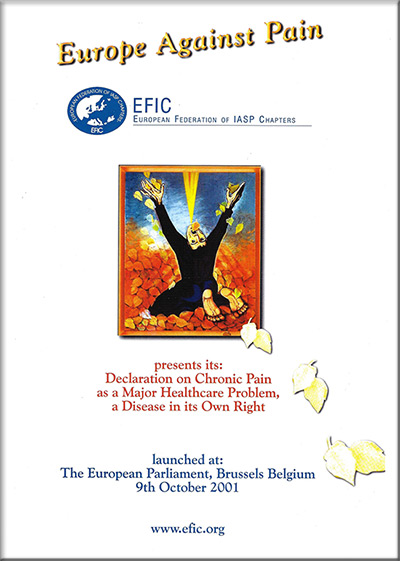 |
|---|
Il concetto in sé, in seguito ampiamente discusso dalla letteratura, era semplice, diretto, comprensibile e, soprattutto, realistico. Il mondo clinico ha stentato molto a comprenderne l’importanza. Molti erano ancora troppo legati al concetto di dolore sintomo (spesso auto diagnostico) di una sottostante malattia. Alcuni, soprattutto nel mondo chirurgico, ritenevano ancora che curare il dolore come prima istanza potesse essere deleterio, per un corretto comportamento clinico nei confronti del malato nei Pronto Soccorsi o anche nelle corsie dell’ospedale. Alcuni altri (ahimè ancora oggi) ritenevano che anche nel malato terminale il dolore potesse rappresentare un ultimo “segnale di vita”. Solo dopo almeno un lustro, quando sono comparsi importanti studi epidemiologici sulla prevalenza del dolore cronico in Europa, si è cominciato a discutere l’argomento in modo più serio e continuativo. Oggi quasi tutti amano riproporlo in ogni possibile occasione ed è quasi impossibile che si parli di dolore cronico senza aggiungere che è una malattia a sé stante. Ripercorrendo alcuni processi storici, e rendendoci conto che per alcuni fra quelli che amano ripetere lo slogan che il dolore cronico è una malattia o addirittura amano fare distinzione fra “dolore sintomo” e “dolore malattia” non sempre il concetto è chiaro, è cruciale fare bene il punto sul perché si è così insistito sulla necessità di introdurre nel linguaggio comune un concetto tanto importante.
Per secoli, la medicina ha ritenuto il dolore una “ancella” utile per il clinico. Per secoli la soluzione del problema era, nel migliore dei casi, un succedaneo della corteccia del salice, quando non una semplice parola di conforto al malato o, in alternativa, l’epiteto di “scocciatore”. Man mano che le conoscenze sulla fisiopatologia del dolore erano rese sempre più chiare dagli studi sperimentali sugli animali e che i meccanismi del dolore divenivano più noti, si è capito che, in determinate situazioni il dolore non funziona più da campanello d’allarme ma è radicato nel cervello ed è di difficile eradicazione o anche sola attenuazione. Purtroppo, questi casi sono i più frequenti, nella clinica di tutti i giorni. Non si ritiene necessario fare esempi. Per alleviare il dolore dei malati che ne sono affetti è cruciale, però, parlare delle conseguenze socio-sanitarie di questa condizione clinica che non ha più nulla a che fare con quanto si era pensato nel passato. Un malato con dolore cronico, non più facilmente eradicabile o curabile, diviene un invalido a tutti gli effetti. Il servizio sanitario di una nazione a forte impatto sociale deve vederlo come tale, soprattutto pensando alla enorme quantità di conseguenze anche sociali, oltre che sanitarie, ed all’incredibile impatto, anche di tipo economico, che il malato ha sul sistema sanitario (1,2).
Questo modello concettuale ha rappresentato la base per il riconoscimento del diabete come malattia cronica invalidante. Un tempo, infatti, essa era solo un sintomo, l’iperglicemia. Quando si è capito quali fossero le devastanti conseguenze di quel “sintomo”, grazie ad una maggiore conoscenza dei meccanismi ezio-patogenetici e fisio-patologici, il diabete è stato inquadrato nel novero delle “malattie croniche” e come tale trattato nell’ambito del SSN. È indiscutibile che i malati con diabete siano trattati oggi molto meglio di quanto lo fossero 30-40 anni fa. È indiscutibile che il loro miglior trattamento abbia contribuito al prolungamento della loro sopravvivenza ma anche della loro produttività sociale.
Ebbene, riconoscere il dolore cronico come una malattia a sé stante, con una propria precisa configurazione, non può che portare verso la stessa direzione. Tale riconoscimento, nell’ambito della medicina di un mondo moderno e civile, avrà la conseguenza di una crescita esponenziale delle condizioni di vita dei malati che quotidianamente soffrono e che solo fino a poco tempo fa erano quasi totalmente dimenticati da un SSN che li guardava con sufficienza e a volte con insofferenza. Per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno senza dubbio di operatori sanitari preparati e specializzati in un settore difficile che non comprende solo il cuore, il fegato, il pancreas o altri organi ed apparati, ma che coinvolge il malato nella sua interezza di corpo e soprattutto mente. Operatori sanitari capaci di guardare ai malati non solo per le loro limitazioni funzionali ma anche per le loro sofferenze spirituali che spesso li costringono a rinchiudersi in sé stessi, abbandonando la vita sociale e familiare.
Di questo si occupa la Fondazione Paolo Procacci, memore del messaggio scientifico ma soprattutto umanitario lasciato in eredità dal grande scienziato a cui essa è dedicata. In questa direzione ha operato e vuole continuare ad operare, ora anche grazie ad una joint venture con la Momento Medico.
1. Langley P, Müller-Schwefe G, Nicolaou A, Liedgens H, Pergolizzi J, Varrassi G. The societal impact of pain in the European Union: health-related quality of life and healthcare resource utilization. J Med Econ. 2010;13(3):571-581
2. Langley P, Müller-Schwefe G, Nicolaou A, Liedgens H, Pergolizzi J, Varrassi G. The impact of pain on labor force participation, absenteeism and presenteeism in the European Union. J Med Econ. 2010;13(4):662-672
Prof. GIUSTINO VERRASSI Presidente Fondazione Paolo Procacci President, European League Against Pain (EULAP) |
|---|
  |
N. 16/2015 - MedTOPICS - Periodico Quindicinale |